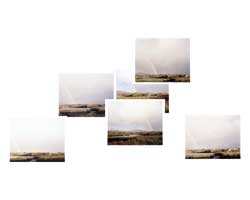|

Nella fotografia di Nunzio Battaglia è
possibile trovare diverse tensioni, differenti storie che si intrecciano.
Le sue fotografie, prese singolarmente, in una ricerca su luoghi e
spazi che da una decina d'anni indica una precisa autorialità,
mostrano infatti una sostanziale fede nella -veduta-, nella singola
immagine prospettica capace di descrivere e narrare un paesaggio complesso
all'esterno e, parallelamente, il paesaggio della cultura di chi quel
paesaggio intende abitare e narrare.
È una modalità che ha una storia abbastanza definita,
quella della nuova fotografia di paesaggio che in Italia si condensa
attorno al lavoro di Luigi Ghirri dagli anni Ottanta, a quello di
Chiaramonte, Barbieri, Cresci, Basilico, Jodice, Castella, Ventura
ed altri; storia parallela a quella contemporanea degli statunitensi
Meyerowitz, Egglestone, Shore. Le singole fotografie di Battaglia
hanno una stesura che rimanda proprio a quella storia: il medio formato
di ripresa e il colore luminosamente acquerellato, il dettaglio accanito
che a tratti impone quasi un eccesso di realtà e a tratti si
ritira nelle rese abbagliate della luce.
La sua fotografia, però, intesa come scrittura e pratica di
una produzione che si disloca nel tempo, procede per serie, sequenze
intrecciate profondamente, sistemi di relazione tra le immagini che
prendono i tratti di una babelica biblioteca il cui orientamento è
oltretutto mutevole, viene continuamente rigiocato nel corso degli
anni. Così delle belle inquadrature troviamo spesso giustificazione
in un -fuori campo-, fatto di altre fotografie o di testi letterari,
o di mitologie suggerite. A volte il gioco sembra quello di un desiderio
analitico al cui fondo si trova l'improponibilità di ogni sintesi
unitaria, una volonta di strutturare il proprio pensiero a ridosso
di un luogo che va a parare nella distruzione della presupposta vocazione
cartesiana della fotografia. Anche questo ha una sua storia; ricordiamo
una delle verifiche di Mulas in cui nel continuo ingrandimento, dal
blow up di una veduta urbana troviamo solo l'insegna di un fotografo
(nella fotografia non troviamo verità che non sia nel suo linguaggio)
oppure gli stravolti réportages di Duane Michals, gli assemblaggi
di David Hockney, in apparenza il referente più prossimo alle
composizioni In-transitive di Nunzio Battaglia.
Possiamo allora leggere queste composizioni di fotografie, o scomposizioni
di vedute (o, come detto da Vittorio Savi, possibili identificazioni
e dis-identificazioni per il lavoro di Battaglia sulle architetture)
alla luce della pop art inglese di oltre trent'anni fa, e in particolare
del suo versante più attento alle implicazioni linguistiche,
concettuali o, per restare in una zona a noi più prossima,
al lavoro fondante di Luigi Ghirri negli anni Settanta del secolo
scorso, e di questo troviamo tante tracce, tanti sottili omaggi. Ovviamente
i luoghi, l'Alpe di Siusi oggetto di una celebre veduta ghirriana
che qui viene raccontata come in controcampo, condensando sul luogo
una serie di quadri analitici che ne dilatano i tempi di percezione,
traducono in gioco combinatorio uno sguardo fortemente affezionato;
poi gli orizzonti, le sequenze che articolano una bellezzza del paesaggio
tra cielo e luce in mondi possibili (a nessuno dei quali si vorrebbe
rinunciare a favore di una bella veduta) dalle sottili variazioni
di tono in una griglia ortogonale che ricorda la serie di Infinito,
sempre di Ghirri.
Ma le seriazioni e le panoramiche esplose di Battaglia dispiegano
sequenze radicalmente diverse da quelle della linea concettuale. Non
sono infatti narrative, in termini cinematografici (più che
alle piccole storie sul linguaggio di Dibbets o Michals sembrano vicine
agli insistiti piani-sequenza di Starub-Huillet) e nemmeno ieraticamente
esplicative come in John Pfahl o Silvio Wolf, inseguono invece una
dilatazione della ricerca sulla bellezza, individuata non tanto nell'unicità
rivelata del momento e del luogo (che insiste, comunque, in ogni punto
di queste storie) quanto nella felice complessità del vedere
e del far vedere.
Si tratta comunque di un fare vedere fondato su un certo straniamento,
non tanto dell'oggetto, del paesaggio -per il quale vi è anzi
un quasi sacrale rispetto- quanto delle abituali condizioni di percezione
della sua scrittura, anche all'interno della stessa operazione. Non
solo viene evitata la fotografia come quadro da parete ma anche il
montaggio esplode in direzioni diverse, volta per volta, o esce dalla
bidimensionalità come in opere costruttiviste, o prende l'aspetto
della cassa retroilluminata. Forse dietro a questo continuo mutare
delle forme della visione (sempre comunque fedele a un'idea di paesaggio)
non vi è tanto un accumulo delle possibili scritture, delle
possibili soluzioni descrittive ed espositive, quanto uno sviare da
ogni sedimentazione delle abitudini, un lavoro -a togliere- che dovrebbe
lasciare, in fondo, una ultima curiosità sulla bellezza del
mondo.
Paolo Barbaro
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
LUCI CELTICHE
Irlanda. Arcobaleni simili all’arco di un dio, lasciato cadere
per trascuratezza al confine tra la terra e il mare; promontori di
sabbia, rocce ed erbe, infestati dai fantasmi; montagne coronate da
tumuli dove vaste nubi celano la presenza della Signora Bianca, la
regina Medb che elargisce l’acqua; alberi tra le cui fronde le
voci si dissolvono nel crepuscolo; e poi paludi di torba, strade,
pendii, dirupi, scogliere popolate di folletti, di donne senza testa,
uomini con la corazza, lepri-ombra, cani da caccia con la lingua di
fuoco, foche fischianti…
“Poggia l’orecchio alla collina. / Non senti il flebile
ticchettio, / Gli indaffarati colpi del martello di un elfo, / La
stridula voce del leprecano che canta / Tutto contento mentre lavora?
“ recita un’antica ballata irlandese.
Cosa raccontano le nuvole basse e iridescenti che corrono veloci sulle
Cliffs of Moher? E le colline ricoperte d’un erba verde, rasata
come il tappeto d’un tavolo da gioco? E i sambuchi, i susini
selvatici, i faggi, gli olmi, i cespugli di fucsie che scendono fino
al mare? “Per il contadino saggio le colline verdi e i boschi
intorno a lui son pieni di un mistero che non svanisce mai” racconta
il poeta W. B. Yeats.
“Poggia l’orecchio alla collina…” suggeriva la
ballata. Ma l’occhio, invece, dove e come deve guardare per non
rimanere intrappolato solo nell’incanto superficiale del bel
panorama?
Facile infatti sarebbe lasciarsi sedurre dalle scenografiche scogliere
dell’Irlanda occidentale, dove nubi di gabbiani vorticano in
danze frenetiche, o dai prati smeraldini che ricoprono morbide colline.
Eppure la tentazione del pittoresco è proprio quella che va
evitata, se non si vuole ridurre la natura a piatta immagine di consumo.
“La passione celtica per la Natura sorge dal senso del suo mistero
piuttosto che dalla sua bellezza” ribadisce Yeats con tenacia.
Ma noi del “Bel Paese” spesso ignoriamo tale mistero: nei
tramonti vediamo solo luci rosate e non immaginiamo schiere di morti
incamminarsi dietro il sole.
E la fotografia poi, figlia del secolo della tecnica e della razionalità,
come può cogliere ciò che va oltre il visibile, ciò
che non è solo spenta e seducente bellezza?
Forse può, come ha fatto Nunzio Battaglia, iniziare col rinunciare
alla “bella veduta”, alle riprese con la luce “giusta”,
alle inquadrature che evidenziano scenografie e meraviglie naturali
a un punto tale da trasformarle in fondali di uno spot pubblicitario.
Nonostante Battaglia fotografi anche le scogliere più celebri
dell’isola
– come le Cliffs of Moher – ci si accorge che, anziché
puntare l’obiettivo verso il bello, egli preferisce fare un piccolo
passo indietro: sembra ritrarsi verso una visione più instabile,
delicata, che rivela come per lui la bellezza del paesaggio non consista
nella veduta mozzafiato cara ai depliant turistici, ma nella misteriosa
Presenza della Natura.
Una Presenza potente e sommessa, che emerge grazie a uno sguardo capace
di ascoltarne i fremiti, di seguire le nuvole lanose accarezzate dal
vento, attendere la discesa del sole, l’affievolirsi di un arcobaleno
in lontananza.
Costruite in sequenze che s’intrecciano e si ramificano, le sue
immagini rivelano il farsi dell’esperienza, dilatano i tempi
della percezione, ma soprattutto mimano e assorbono il ritmo latente
e mutevole del paesaggio irlandese.
Lontano da tentazioni concettuali, Nunzio Battaglia moltiplica le
immagini non per destrutturare le certezze della visione, ma per sfuggire
alle facili illusioni ottiche del troppo bello, e far emergere invece
un’altra bellezza, fatta di forza e incantamento, aura e mistero.
“Le parole sono sempre ostaggi; appena concesse al mondo profano,
subito questo ne fa reti, gabbie. Come preservare il significato dalla
fatale sorte d’ogni significante?” si chiede Elémire
Zolla, che suggerisce: “Consiglio di cambiare costantemente la
parola. (…) In guardia dall’ipnosi dei termini, delle formule.
Variamoli viceversa, senza indugio. A vortice.
I canti sciamanici sono rosari di sinonimi, la loro moltiplicazione
dei simboli è vertiginosa.”
Ecco, forse le immagini di Nunzio Battaglia – come le parole
cangianti suggerite da Zolla – si frantumano e si moltiplicano,
simili ai sinonimi degli sciamani. In questo modo sfuggono alla gabbia
delle definizioni univoche. E delicatamente, intensamente si sporgono
al di là del dominio delle mere parvenze, delle belle forme.
Gigliola Foschi
|
|
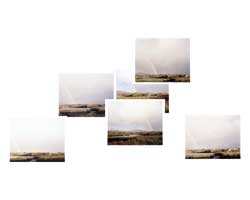
Ring
of Kerry, Installazione, 2002
|
|
|
|

Ring
of Kerry, Irlanda, 2001
|
|
|
|

Penisola
Dingle, Installazione, 2002
|
|
|
|

Penisola
Dingle, Irlanda,
2001
|
|
|
|

Cliff of Moher,
Installazione, 2002
|
|
|
|

Cliff of Moher, Irlanda,
2001
|
|
|
|